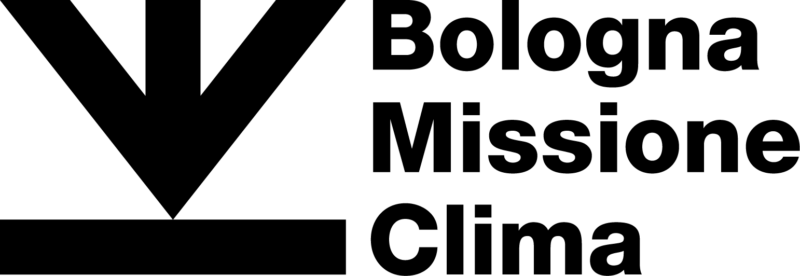Quando si parla del rapporto tra filiera agroalimentare, salute e ambiente, le realtà locali sono motore di innovazione. Abbiamo fatto due chiacchere con Kilowatt, EtaBeta e CampiAperti.
Il nostro sistema alimentare ha un impatto negativo sul Pianeta e sulla nostra salute. Oltre a contribuire drasticamente alle emissioni di gas serra.
A sostenerlo sono scienziati e organizzazioni di tutto il mondo che lanciano l’allarme sulla necessità di intervenire, da una parte sul sistema di produzione agricolo e, dall’altra, sul consumo individuale di prodotti di origine animale.
In particolare, un recente studio della Chatham House condotto con il supporto del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, ha evidenziato come il sistema alimentare sia responsabile di circa il 30% delle emissioni globali raggiungendo la ragguardevole cifra di 20 miliardi di tonnellate l’anno. Tale scenario è il risultato di molteplici fattori che coinvolgono l’intera catena produttiva: a partire dall’utilizzo del suolo per attività agricole e allevamenti, che occupa quasi il 40% delle emissioni complessive dei sistemi alimentari, alla lavorazione dei prodotti e la distribuzione delle merci passando per l’uso di pesticidi e fertilizzanti.
Secondo la Chatham House, più dell’80% del suolo agricolo a livello globale è utilizzato per la produzione di cibo destinata all’allevamento ma, proprio quest’ultimo fornisce solo il 18% delle calorie di cui si nutre l’uomo. Se nei territori adibiti a pascolo in tutto il mondo fosse ripristinato il sistema boschivo preesistente, quest’ultimo sarebbe in grado di trattenere o, come si dice in termini tecnici, “stoccare” circa 72 miliardi di tonnellate di CO2, corrispondenti a circa 7 anni di emissioni derivanti dai combustibili fossili.
Un simile modello di sviluppo, inoltre, ha ovvie ripercussioni sugli ecosistemi e sulla fauna selvatica a cui ruba letteralmente ettari ed ettari di suolo: basti pensare che dal 1970, secondo il Living Planet Report 2020 del WWF, la fauna selvatica è diminuita del 68% mentre la massa degli animali allevati, e in particolare di mucche e maiali, costituisce il 60% di quella di tutti i mammiferi del Pianeta. Dato, quest’ultimo, di cui il 36% è rappresentato dall’uomo e solo il 4% dagli altri animali.
A voler interrompere questo schema indubbiamente dannoso per l’ambiente, otterremo anche benefici che includono un miglioramento delle condizioni di salute dell’intera umanità, come richiesto peraltro dal terzo obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG 3). Al momento, infatti, circa 3 miliardi di persone soffrono di problemi di salute legati alla malnutrizione o ad una dieta sbilanciata – che porta ad obesità e sovrappeso – con costi che si ripercuotono sia sugli individui che sulla società nel suo complesso, e che riguardano il sistema sanitario e gli ecosistemi. Secondo la FAO, il mantenimento dell’attuale modello di consumo alimentare comporterà un costo per il sistema sanitario pari ad una media di 1,3 trilioni di dollari entro il 2030 di cui il 57% sarà rappresentato da costi sanitari diretti in quanto sono associati alle spese relative al trattamento delle diverse malattie legate alla dieta, e un 43% da costi indiretti che comprendono le perdite di produttività del lavoro (11%) e l’assistenza informale (32%). Il risultato è una bomba ad orologeria per la società e per un pianeta di cui noi, ricordiamocelo sempre, facciamo parte.
E questa parte, spesso e volentieri, la fanno le realtà locali con la loro profonda conoscenza del territorio e del tessuto socio-culturale che lo caratterizza. Ne è convinta Elena Hogan, Coordinatrice dell’associazione bolognese Campi Aperti, che spiega come la relazione tra tutela ambientale, salute, agricoltura industriale e grande distribuzione sia centrale: “questo sistema è un vero e proprio suicidio – afferma Hogan – e la situazione è destinata a peggiorare visto che si prevede che le emissioni dovute all’agricoltura aumenteranno del 35% entro il 2050”. Preoccupazione condivisa anche dal Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) che, nel report speciale sui cambiamenti climatici e l’uso del suolo, sottolinea come circa il 23% delle emissioni di gas serra di origine umana provenga da agricoltura, silvicoltura e altri usi del suolo. E ancora, che l’agricoltura è responsabile di circa la metà delle emissioni di metano indotte dall’uomo ed è la principale fonte di protossido di azoto, due gas ad effetto serra molto potenti.
A voler dare un’occhiata alla situazione a livello regionale, scopriamo che al settore agricolo è imputabile il 6% delle emissioni di PM10 e del 98% di ammoniaca, di cui il 75% da scarichi reflui. Un impatto che coinvolge anche la qualità dell’aria, come dimostrano i risultati prodotti nell’ambito del progetto Life Prepair che evidenziano come nel bacino padano circa il 97% delle emissioni di ammoniaca derivino dall’agricoltura e dalla zootecnia. Nel solo territorio bolognese l’agricoltura è invece responsabile dell’emissione di 41,7 tonnellate di ammoniaca e 13,6 tonnellate di metano nel solo anno di riferimento (2017).

Emissioni suddivise per settore nel territorio di Bologna. Fonte: INEMAR 2017
“Dati ancora più assurdi se pensiamo – continua Hogan – che a dare da mangiare al mondo non è il sistema della grossa distribuzione, che sfama solo il 30% della popolazione mondiale, bensì i piccoli produttori”. E di questi piccoli produttori, Campi Aperti ne ha inclusi ben 150 nei suoi 20 anni di attività. Nata nel 2001 come coordinamento per la Sovranità Alimentare, un concetto che indica l’insieme delle politiche volte a mantenere il controllo delle comunità sui sistemi agricoli locali minacciati da organizzazioni e accordi internazionali sul commercio, Campi Aperti si costituisce come associazione nel 2007 e, forte del suo ben radicato rapporto sul territorio bolognese, non ha mai smesso di credere nell’importanza di una forma di produzione agricola contadina, sociale, etica, familiare e sostenibile.

Mercato contadino a Bologna. Fonte: Campi Aperti
“Campi Aperti lavora per creare una rete di comunità che – sostiene Hogan – si basa sulla fiducia reciproca, sul rapporto diretto e sulla volontà di decidere tutti insieme il prezzo dei prodotti che finiscono nei mercati”. Perché la sostenibilità di un prodotto è frutto anche della dignità di chi lavora per produrlo: da chi infila le mani sulla terra tutti i giorni, a chi va al mercato per vendere. “Noi, e solo noi abbiamo la responsabilità del nostro lavoro. Quello che vogliamo è togliere di mezzo la speculazione e fare un patto con la comunità assicurando a tutti la possibilità di mettere sul piatto del cibo sano, che nasce da un lavoro onesto”. E a chi pensa che mangiare bene costi troppo, risponde che “il cibo a basso costo che finisce sulle nostre tavole è il risultato di una vera e propria speculazione fatta sulla pelle dei lavoratori, costretti a stipendi miseri, e sulla nostra salute, a causa di prodotti chimici e processi di produzione dannosi. Questo meccanismo, in Europa, è anche il risultato di una Politica Agricola Comune (PAC) che emette sussidi ingenti a favore della grande industria alimentare a danno di altri sistemi di produzione e distribuzione agro-ecologici”. Sarebbe dunque necessario, secondo quanto afferma Hogan e quanto si legge sul documento elaborato da Campi Aperti, “una vera e propria rivoluzione culturale” che l’associazione, da parte sua, sta cercando di promuovere chiedendo “una più equa distribuzione dei sussidi che, invece che agevolare solo i grandi produttori, sia a favore dei piccoli agricoltori e della produzione di prossimità di cui non si sa ancora abbastanza”.

Sostenibilità dal produttore al consumatore. Fonte: Campi Aperti
Una lacuna, quella educativa, che Campi Aperti cerca di colmare attraverso iniziative, campagne di informazione, collaborazioni con altre associazioni, gruppi e istituzioni al fine di promuovere l’incontro tra produttori e consumatori responsabili, così come attraverso progetti come quello sulla sovranità alimentare, che promuove la creazione di un programma politico e di una rete regionale che crei un reale cambiamento culturale e politico anche a livello legislativo.
“Bisognerebbe investire nell’autoproduzione e nella creazione e valorizzazione di ampi spazi verdi all’interno dei nuclei urbani”. Ne è convinto Niccolò Rizzati, agronomo che collabora con la cooperativa EtaBeta e che ha all’attivo esperienze di sviluppo di progetti agricoli locali nella Striscia di Gaza e in Birmania, oltre che a Bologna e Piacenza.
“È ovviamente impossibile – continua Rizzati – pensare di eliminare le grandi coltivazioni ma se potenzialmente ognuno riuscisse a ritagliarsi uno spazio per l’autoproduzione, o se ci fossero più cooperative agevolate dalle istituzioni per creare progetti locali e sostenibili per produrre e vendere a chilometro 0, l’impatto sull’ambiente si ridurrebbe molto. L’Università di Bologna, ad esempio, ha condotto studi che evidenziano che la coltivazione negli spazi verdi e sui tetti piani del territorio urbano di Bologna porterebbe una produzione di 12000 t di ortaggi ogni anno, soddisfacendo il 77% delle necessità degli abitanti. Il risultato? Un gran quantitativo di verdura prodotta localmente e un’altrettanta grande quantità di radiazione solare assorbita che equivale a meno ondate di calore e un miglior comfort urbano”.
EtaBeta è una cooperativa sociale onlus che nasce nel 1992 sotto forma di Associazione tra artisti impegnati nella ricerca e nella sperimentazione di materiali, con un’attenzione particolare al sociale. Le parole chiave con cui si presenta, e in cui crede fermamente, sono educazione, salute e sostenibilità sociale.
Tra i progetti coordinati dalla cooperativa, a cui collabora dal maggio 2020 anche Rizzati insieme al collega Enrico Marulli, vi è la creazione di un corridoio eco-ciclo-ortivo che vede la partecipazione, insieme a Eta Beta, del comune di Bologna, del Dipartimento di Scienze Agrarie di UniBo, e dello Studio di Architettura Tasca, e che partendo dalla Stazione Ferroviaria Roveri si sviluppa su via delle Biscie, costeggiando i terreni di Eta Beta e lo Spazio Battirame, fino ad arrivare alla Facoltà di Agraria, al CAAB e a FICO. “Questa fascia di terra di circa 6 ettari – racconta Rizzati – destinata negli anni ‘70 alla costruzione di un nodo ferroviario per il trasporto delle merci mai realizzato a causa di un errore di progettazione, è rimasta dapprima incolta e poi destinata ad agricoltura estensiva. Quello per cui stiamo lavorando è la riqualificazione dell’intera area affinché sia destinata ad un uso sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale”.

Corridoio eco-ciclo-ortivo. Fonte: EtaBeta
Per farlo, EtaBeta si avvale del supporto del Comune di Bologna e del bando regionale che consentiva l’acquisto di piante finalizzate all’espansione di spazi popolati da piante autoctone nei territori regionali. “Una parte del territorio – spiega Rizzati – è un vero e proprio corridoio ecologico: è, infatti, lasciato alla natura e accoglie insetti, tra cui ovviamente gli impollinatori, ma anche volatili e altri animali; una parte è dedicata alla piantumazione di erbe aromatiche che vengono utilizzate da un’azienda locale che produce cosmetici a partire da distillati di piante biologiche; un’ultima parte è destinata a frutteto e ortaggi. Tutti gli spazi sono pensati per seguire i principi dell’agricoltura biologica e sinergica, con avvicendamenti colturali, tutela della biodiversità e adeguato riposo del terreno dopo le coltivazioni orticole. Queste attività, come si legge nella pagina dedicata al progetto, permettono lo sviluppo di EtaBetaBio, ramo d’azienda che consiste nella produzione e distribuzione di verdura alle famiglie, ai gas del territorio bolognese e ai “MERCATI DEL NOVALE” gestiti da EtaBeta coop. Una filiera cortissima, dal produttore al consumatore e con un’attenzione particolare alle tematiche dell’inclusione. EtaBeta, infatti, ha avvitato da dicembre 2020 e in collaborazione con il quartiere Pilastro, un percorso di inserimento di ragazzi fragili che hanno avuto un passato turbolento tra carcere e tossicodipendenza. Il progetto prevede 3 mesi di formazione alle tecniche di coltivazione di prodotti biologici, 3 mesi di tirocinio e una successiva, eventuale, assunzione.
E alla domanda “mangiare bio costa davvero troppo?”, anche Rizzati risponde “Dipende. Ci sono realtà che effettivamente fanno costare caro il cibo biologico rispetto a quello che proviene dalla grande distribuzione. Ma questo prezzo, che statisticamente varia dal 10 al 25% in più, si giustifica con le ricadute positive che la sua produzione ha sul territorio e sulla salute delle persone. Sono scale diverse. Mangiare i nostri prodotti equivale a dare valore non solo al lavoro di persone che cercano una seconda possibilità nella società, ma anche al rispetto e alla tutela ambientale, il tutto ad un prezzo competitivo con le linee biologiche della grande distribuzione. Credo che un unico ortaggio capace di esprimere tutti questi aspetti assuma un grande valore”.

I terreni agricoli di EtaBetaBio. Fonte: EtaBeta
“Certo – ammette Rizzati – fare agricoltura rispettosa dell’ambiente non è facile. È una sfida ma vale la pena coglierla. E tra tutti i luoghi che rappresentano un’opportunità, le fasce periferiche limitrofe ai grandi centri urbani sono nella posizione più favorevole per la realizzazione di tali progetti, fasce tampone potenzialmente capaci di trarre i vantaggi del mondo rurale (presenza di spazi incolti e superfici agricole anche di grandi dimensioni) e del mondo urbano (vicinanza al consumatore finale). Per il resto, una larga parte del lavoro sta nel facilitare un cambiamento culturale nelle persone, così come nelle istituzioni”.
Un cambiamento che deve iniziare con l’educazione alla sostenibilità. Ne è convinta anche Nicoletta Tranquillo, co-fondatrice di Kilowatt e project manager esperta di impatti “siamo convinti che il rapporto tra alimentazione e ambiente sia un tema centrale, perché se da un lato il cibo e la sua produzione possono avere un grande impatto dall’altro c’è un enorme cambiamento positivo che si può generare laddove le persone decidono di intraprendere scelte diverse”. Una visione che, alle Serre di Kilowatt si concretizza in una profonda attenzione per gli impatti che gli alimenti possono avere sull’ambiente e sui clienti. “Il 75% delle materie prime che compriamo e serviamo al Bistrò, all’asilo che ospitiamo nella nostra sede e alla mensa per i nostri dipendenti, sono locali e stagionali. Si basano sui principi di una dieta vegetariana e sono stati elaborati con il supporto di una serie di nutrizionisti con cui abbiamo collaborato per creare proposte equilibrate e sane”.
“Quello che proponiamo – continua Tranquillo – è una trasformazione nel modo in cui le persone concepiscono il cibo. Vogliamo far capire loro quanto sia importante una dieta sana, per loro, per i loro figli e per l’ambiente. Alcune scelte, ovviamente, possono destare sospetti se lontane dalla cultura tradizionale di una persona ma, proprio per questo, ci affidiamo sempre a professionisti che accompagnano noi, e i nostri ospiti, lungo un vero e proprio percorso in cui sperimentiamo buone pratiche che, una volta accettate, possono essere felicemente replicate a casa così come in altre realtà”.

Dieta sana e convivialità. Fonte: GREAT community
Un impegno che Kilowatt, cooperativa che non è solo uno spazio di coworking, ma anche incubatore di idee e un luogo di incontro tra microimprese e professionisti attivi nella progettazione, nello sviluppo sostenibile, nella comunicazione e nella creatività porta avanti non solo nella sua sede, e nella definizione del programma del Festival Resilienze, ma anche nei progetti internazionali a cui lavora. Un esempio è GREAT, progetto europeo (Programma Life) con capofila il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna e come partner Kilowatt, Alce Nero, Comune di Cento e LCE.
“GREAT – racconta Tranquillo – ha l’obiettivo di mettere insieme la filiera, dai produttori ai consumatori passando per i trasformatori del prodotto, così da portare sul mercato prodotti agricoli resilienti al cambiamento climatico. La chiave per farlo è sperimentare nuove colture resilienti, a partire da miglio e sorgo, che riducano l’impatto del cambiamento climatico sulle attività agricole della Valle del Po e dell’Italia nel suo complesso, contribuendo a sostenere il reddito dei coltivatori, a ridurre il consumo di risorse idriche e a produrre cibi di qualità per il mercato finale”.

Miglio e Sorgo: i cerali coltivati nell’ambito di GREAT. Fonte: GREAT community
La coltivazione di miglio e sorgo si basa sulla tecnica del miscuglio evolutivo, sperimentato dall’agronomo Salvatore Ceccarelli, che consiste nel seminare in campo non una varietà uniforme (come una sola specie di grano) ma un insieme di piante geneticamente diverse tra loro. “Questo significa – spiega Tranquillo – che le piante non sono cloni ma ognuna ha le sue caratteristiche genetiche e, per questo, evolvono in modo indipendente per adattarsi al contesto. Miglio e sorgo, poi, hanno una ricchezza nutritiva alta rispetto al mais, che è sempre più raffinato. A questo si aggiunge il fatto che non contengono glutine – sono quindi adatti anche ad una dieta senza glutine – hanno proteine e anticamente venivano coltivati in questo territorio. Non per niente, Borgo Panigale deve il suo nome al termine latino Panicus, ossia miglio”.
Quella che cresce attorno al progetto GREAT è ora una grande comunità di circa 400 tra professionisti e persone appassionate che vogliono saperne di più di questo nuovo modo di concepire il cibo e l’agricoltura. Un’onda che ha investito le scuole “perché – dice Tranquillo – siamo convinti che l’educazione ad un’alimentazione sana e rispettosa di sé stessi e del Pianeta debba iniziare da piccoli” e alcune realtà come i Panificatori Agricoli Urbani ai quali i partner del progetto GREAT regalano miglio e sorgo chiedendo loro di creare delle ricette da proporre ai loro clienti “per avviare una vera e propria trasformazione culturale che può arrivare nella tavola di chiunque”.
Tratto comune di tutte le realtà descritte, da Kilowatt a CampiAperti ed EtaBeta, è indubbiamente il carattere innovativo e la volontà di sostenere tutti e tre i pilastri della sostenibilità – sociale, economica, ambientale – senza lasciare indietro nessuno, favorendo il dialogo, incentivando l’educazione e promuovendo percorsi didattici rivolti a tutte le età e facendo particolare attenzione alle fasce fragili della popolazione.
Un compito importante che necessita di attenzione e supporto da parte dei cittadini, che possono premiare queste realtà – e come loro ce ne sono tante altre, a Bologna così come altrove – scegliendo di comprare i loro prodotti e frequentando le loro sedi, così come dalle istituzioni che hanno la responsabilità di facilitarne l’accesso ai finanziamenti, promuoverne gli sforzi e sostenerne le attività anche attraverso lo snellimento delle pratiche burocratiche.
Valeria Barbi – Fondazione Innovazione Urbana
Politologa e naturalista, Valeria si occupa di cambiamenti climatici e sostenibilità, dapprima nell’ambito della ricerca e dello studio delle politiche, e poi degli impatti sugli ecosistemi e l’ambiente urbano. E’ divulgatrice scientifica e, per la Fondazione, coordina i progetti europei e collabora al progetto editoriale Chiara.eco