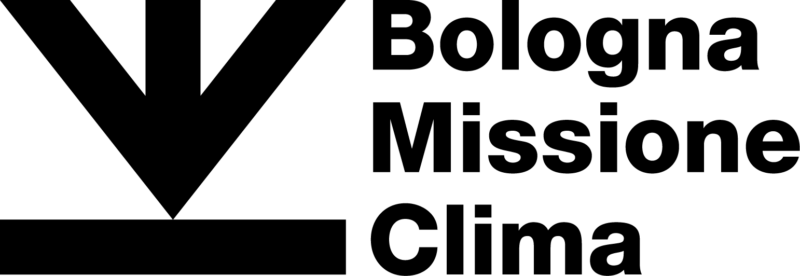La nuova centrale del Cavaticcio produce elettricità dal movimento dell’acqua: il sistema idroelettrico è considerato una delle chiavi verdi per la transizione ecologica.
L’idea di sfruttare l’energia dell’acqua è antichissima – più di duemila anni – e ha prodotto nella storia una moltitudine di ruote idrauliche, macine, mulini. È naturale dunque che nel 1800, quando le tecnologie elettriche divennero mature, le ruote dei mulini fossero sostituite con turbine e trasformatori in grado di convertire l’energia dell’acqua in movimento di elettroni. Fu una corsa all’acqua: la prima centrale idroelettrica del mondo entrò in funzione nel 1881 per convertire la potenza delle cascate del Niagara in luce, in nemmeno 10 anni gli Stati Uniti ne possedevano già 200. In Europa il Klondike dell’idroelettrico erano le Alpi, dove l’acqua si muove velocemente lungo alte pendenze, e l’Italia seppe sfruttare questa fonte illimitata e rinnovabile, usando la velocità dei torrenti, costruendo dighe e creando salti d’acqua artificiali. La prima centrale del nostro Paese è del 1895 e solo nel 1905 eravamo al primo posto in Europa per il consumo di energia idroelettrica. Negli anni ’20 e ‘30 del secolo, praticamente tutta l’elettricità che correva nei cavi italiani derivava dai corsi d’acqua. Il distretto industriale di Terni – cresciuto ai piedi della cascata delle Marmore – era il più grande bacino idroelettrico del continente. Eravamo, insomma, il paese dell’acqua, il “carbone bianco”. Poi arrivò il carbone, quello vero.
L’idroelettrico è ancora la prima fonte rinnovabile in Italia
Oggi, dopo anni dedicati al fossile, la pressione della decarbonizzazione sta velocemente facendo contrarre le fonti sporche. Se solo nel 2010 in Italia gas e carbone coprivano quasi l’80% della produzione elettrica, l’anno scorso è avvenuto il pareggio: nel 2024 la metà dell’elettricità (49,8%) è stata prodotta con fonti rinnovabili. Tra queste, l’acqua è la principale fonte energetica rinnovabile. Ha rappresentato infatti circa il 17% della domanda italiana: una produzione idroelettrica generata dai quasi 5.000 impianti diffusi in tutto il Paese ma concentrati principalmente lungo l’arco alpino (Piemonte, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto).
Perché fare energia con l’acqua
Fare elettricità con impianti idrici offre numerosi vantaggi, oltre a quello di ottenere energia senza bruciare fonti fossili: gli impianti hanno lunga vita operativa, riescono a fornire energia in modo continuo e coi bacini hanno la possibilità di stoccare per mesi, se non per anni, energia potenziale: l’acqua fermata dalle dighe funziona infatti come una batteria in cui una grande quantità di acqua (e di energia) rimane in attesa di entrare in azione, così da modulare la produzione in base alla domanda. Per farlo esistono anche molti impianti idroelettrici – generalmente conteggiati a parte nelle statistiche del settore – chiamati impianti di pompaggio: di notte, quando l’energia è abbondante e costa poco, sfruttano l’elettricità di rete per portare l’acqua a monte; di giorno invece la rilasciano a valle per gravità, producendo così elettricità quando serve di più.
Luci e ombre dell’idroelettrico
Quello idroelettrico è considerato un settore strategico per affrontare la crisi climatica: l’Agenzia internazionale dell’energia prevede che a livello mondiale questa tipologia di produzione rimarrà la più grande fonte di generazione di elettricità rinnovabile fino al 2030 e che in seguito supporterà le tante produzioni elettriche eoliche e fotovoltaiche che si stanno sviluppando in questi anni. Per questo motivo la raccomandazione è che gli impianti esistenti siano resi ancor più efficienti con nuove tecnologie. Tuttavia, in Italia – dove il 67% degli impianti è anteriore al 1960 – ci sono fattori limitanti che si oppongono all’ammodernamento. Il primo è dovuto ad un rallentamento sugli investimenti: l’UE ha chiesto all’Italia di aprire il mercato delle concessioni alla concorrenza, una situazione ancora in stallo, che disincentiva gli attuali concessionari a investire e che ha convinto molte sigle ambientaliste a sottoscrivere un appello per sbloccare la situazione. Il secondo fattore è connaturato alla risorsa da usare: la diminuzione delle precipitazioni medie e la siccità causata della crisi climatica (negli ultimi 30 anni abbiamo diminuito di quasi il 20% la disponibilità idrica) limita la risorsa con cui ricavare energia pulita. C’è poi un limite alla costruzione di nuovi grandi impianti, perché è difficile trovare nuovi siti e non è sottovalutabile il loro impatto ambientale, soprattutto sugli ecosistemi acquatici.
Il nuovo idroelettrico: piccolo e polifunzionale
La nuova tendenza dell’idroelettrico sembra non essere più quella di costruire grandi impianti impattanti, ma di dedicarsi a scale più piccole: secondo Enel a fine 2021 la classe dimensionale più vasta (73,4%) è quella degli impianti con potenza minore o uguale a 1 megawatt. L’ANBI, l’associazione dei consorzi di bonifica – gli enti che gestiscono la rete idrica agricola di superficie – hanno presentato un piano che prevede la realizzazione di 10.000 accumuli artificiali di acqua piovana e che hanno molte funzioni: catturare acqua piovana e frenare la sua corsa verso il mare (una necessità per l’agricoltura in scarsità idrica), offrire spazi di espansione per i corsi d’acqua, creare aree umide dedicate alla fitodepurazione e produrre energia, sia con pannelli fotovoltaici galleggianti – una prospettiva applicabile anche ai grandi bacini idroelettrici – sia muovendo turbine grazie a salti d’acqua artificiali. In particolare, il Piano Invasi prevede la realizzazione 76 piccole centrali idroelettriche.
È una delle tante soluzioni basate sul mini-idroelettrico, una tipologia di impianto che ha una capacità molto bassa (a seconda della definizione sta sotto i 3-10 MW) e che è progettato proprio per sfruttare l’energia di corsi d’acqua minori o di canali artificiali. Il mini-elettrico può integrarsi efficacemente in un contesto urbano, fornendo energia pulita e sostenibile. Spesso è realizzato in aree periferiche di una metropoli, come ad esempio l’impianto di Milano, a pochi metri dalla fermata della metropolitana di Cascina Gobba / Crescenzago, dove il fiume Lambro garantisce elettricità compatibile con le necessità di circa 1.300 famiglie.
Quello del Cavaticcio di Bologna invece è un raro impianto di mini-idro urbano che fornisce energia pulita in pieno centro storico. Dopo anni di inattività, questa centrale è stata oggetto di una importante operazione di revamping conclusa nel mese di ottobre 2024, grazie al quale sarà in grado di produrre circa 2500 MWh all’anno, equivalente al fabbisogno di circa 1200 famiglie.